

 |
Emanuela Vacca (Milano, 1953) vive e lavora a Cassano
d’Adda. Scrittrice e fotografa, ha pubblicato una raccolta di romanzi
dal titolo Scritti tra la penna e
la Luna e il romanzo, Io donna.
Nel 2004 ha vinto il premio Marguerite Yourcenar con il racconto La tana e l’anno successivo è arrivata nei primi posti del
concorso Angela Starace, promosso dalla città di Napoli, con il
racconto Noi due. Dal 1996 al
2003 ha collaborato, assieme ad altri autori, con le riviste letterarie Cafè
Matique, Zero Est, Clippers, Hevelius Web Magazine e con i siti di
storia antica duepassinelmistero.it e medievale.it.
Nella fotografia ha esordito con reportage sull’ex-linificio e il
Castello Visconteo di Cassano d’Adda e sulle cascine lombarde. Nel
2012 e 2013 ha collaborato con il Comune di Cassano d’Adda alla
realizzazione del catalogo Ecoismi
su opere d’arte ecologiche. |
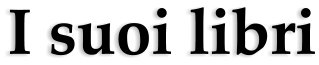
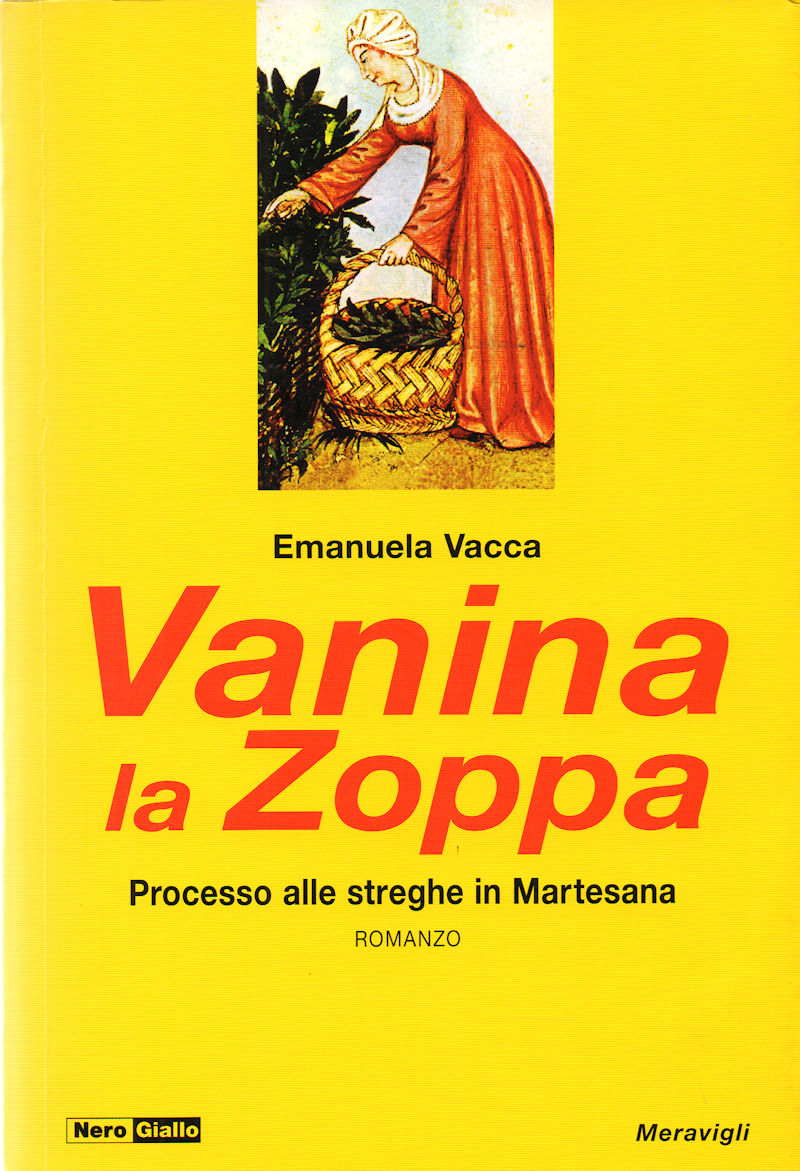 |
|
La storia di
Vanina la Zoppa è ambientata a Cassano d’Adda, a cavallo tra il 1519
e il 1520. Un momento di passaggio turbolento e instabile. A quel tempo,
il Ducato di Milano era controllato dai francesi, ma ai suoi confini
premeva l’esercito dell’Imperatore Carlo V che puntava ad annettersi
la ricca Lombardia. Dopo la dominazione dei Visconti e degli Sforza,
Cassano, e gran parte della Gera d’Adda, erano diventate terra di
nessuno. Un territorio ambito e conteso e quindi soggetto a ogni sorta
di ruberie. Un territorio insicuro e pericoloso, dove la popolazione
assisteva indifesa a scorribande di soldataglie. Francesi e veneziani,
che depredavano, saccheggiavano e profanavano tutto ciò che
incontravano. In questo contesto si inserisce la vicenda realmente
accaduta a Vanina detta la Zoppa di Pontirolo, Leonarda d’Inzago e
Caterina de’ Cerbalii di Pontirolo Nuovo, processate per stregoneria
dal Tribunale dell’Inquisizione, assieme ad altre due donne, nel
gennaio del 1520. Nella storia, accanto a personaggi realmente esistiti
ne compaiono altri che, pur prendendo spunti da documenti di quello
stesso periodo, sono frutto della fantasia dell’autrice. Vanina con
ogni probabilità, era una “donna herbana”, che conosceva le
proprietà e l’uso delle erbe. Conoscenze che, quasi sicuramente,
decretarono la sua condanna, la sua morte, in una gelida mattina
d’inverno, su una pira innalzata sulla piazza antistante l’imponente
castello di Cassano, in Martesana. |
|
Introduzione Il bosco di Tuneda
era una bella distesa di alberi e sottobosco di circa 700 pertiche. Sito tra Groppello
d’Adda e l’attuale cascina Romilli, era di proprietà
dell’Arcidiocesi di Milano e fino ai primi decenni del Novecento
vegetava ancora rigogliosamente. Al suo posto vi è
una grande cava, a lungo utilizzata per l’estrazione della sabbia
destinata all’edilizia. Il bosco di Tuneda
( o Teneda), oltre a essere un rigoglioso polmone verde, nel medioevo
era luogo d’incontro utilizzato dai contadini della zona per celebrare
feste pagane. Il termine
“pagano” deriva da pagus,
che significa villaggio; gli abitanti del pagus
erano appunti i pagi o
“pagani”. Quindi pagano corrisponde ad “abitante del villaggio”.
I pagi, risiedono distanti dai centri abitati più grandi, erano
rimasti legati alla religione primigenia, alla Dea madre, Demetra o
Artemide, divinità consacrate alla fertilità, all’abbondanza, alla
nascita. Il pagus
era un uomo semplice e
pratico, che aveva con gli dèi un rapporto intimo e diretto. Aveva un
forte legame con la Natura, che rispettava in ogni sua forma,
riconoscendola come parte del Divino. Legame sancito da rituali che
potevano essere differenti in zone montane o lacustri, ma in tutti si
riconosceva come dominante, come espressione di un pensiero collettivo,
la divinità femminile. La religione
cristiana e, in seguito, il pensiero illuminista hanno investito molta
energia nel tentativo di esiliare e bandire le religioni animiste quali
il druidismo, lo sciamanesimo e le tradizioni celtiche, i cui rituali
erano ritenuti fonte di superstizione e minaccia all’egemonia del
potere patriarcale. Le antiche
religioni contavano, al loro interno, figure come il sacerdote
“druida”, lo “stregone” e la donna herbana”. Personaggi che
praticavano rituali discutibili, persino strani, ma indispensabili a un
culto che li concepiva come tramite con l’universo. Essi furono in
seguito perseguitati e condannati dalle religioni monoteiste. In
particolare “la donna herbana”, “Strega”,
forse da strix, strigis: corruzione del termine latino che indica in barbagianni. Il
nome deriva dallo stridio notturno che emette questo rapace. La
tradizione mescolava il volo notturno della strega con quello di questo
uccello predatore. Da qui il nome. In alcuni dialetti italiani esso
viene tramutato in “strie”, le streghe dei boschi e degli antri. La
stega moderna è un impasto tra la Lilith degli Ebrei, la Lamia e la
Janara. Le streghe sono presenti in tutte le culture agricole,
continuatrici di un paganesimo che adora e serve la Terra,
rappresentanti del vecchio matriarcato, ultimo baluardo di una religione
femminile preistorica. Una cultura agreste, dove l’energia della Terra
unita a quella dell’Acqua celebra l’antica Demetra, madre e
protettrice della Fecondità. Forse oggi streghe
e stregoni farebbero parte di correnti ecologiste, in difesa della
natura, dell’ambiente e degli animali, e la Chiesa li accetterebbe di
buon grado nel suo grembo… Vanina Camminava
dondolandosi sui larghi fianchi. Sembrava danzasse, le gonne leggermente
sollevate per sostenere il grembiule colmo di erbe. I capelli ribelli
sfuggivano alla cuffia che ormai aveva perso il suo candore, dopo la
giornata trascorsa. Il passo circospetto e gli occhi chiari che
scrutavano ora il terreno scosceso ora i margini della radura. Si era
spinta fin nel folto del bosco per raccogliere le sue preziose erbe. La
strada era stretta e lei posava un piede davanti all’altro per non
perdere l’equilibrio, quel piede che spesso le causava dolori. Buttava
l’occhio ai bordi della boscaglia, guardinga attenta a ogni rumore, a
ogni fruscio. Temeva incontri inaspettati con cinghiali coi piccoli al
seguito, volpi, faine. A volte persino qualche lupo affamato si spingeva
fin giù, nella pianura. E forse fu proprio questa concentrazione
esagerata che le impedì di vedere la grossa pietra. Sporgeva da un
cespuglio della fitta macchia. Il
dolore lancinante la costrinse a fermarsi. Si sedette sul grosso masso a
esaminare il piede. Era storpia; per questo la gente l’aveva
soprannominata “la Zoppa”. Vanina che, mormorava la gente, invece di
pensare a prendere marito e farsi una famiglia, perdeva tempo nei boschi
a raccogliere piante. Quel
pensiero la riempì di rabbia e un lamento le sfuggì dalla bocca. Il
piede si era piegato in un’angolazione strana, che non faceva
presagire nulla di buono. Provò con delicatezza a muoverlo ma uno
spasimo le imperlò la fronte. Improvviso,
un fruscio le fece distogliere l’attenzione. Lentamente sfilò il
grosso coltello che portava alla cinta. Immobile, seduta, col piede
ferito, era sicuramente una facile preda per animali feroci o briganti.
Sollevò lo sguardo e lo vide. A pochi passi, immenso e poderoso. ……cosa
avrà visto Vanina? Il
seguito del romanzo lo trovate nel libro “Vanina la Zoppa”, in
vendita anche presso l’edicola di corso
Europa a Cassano d’Adda e nella cartoleria di Luigi Mapelli in piazza
Maggiore 10 a Inzago.
|